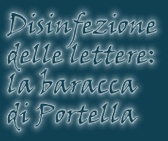Sei isole tematiche per raccontare la paura delle pestilenze
NELLA STORIA DELLE MALATTIE e della lotta intrapresa dall’uomo per combatterle, è stato detto autorevolmente che “il caso dell’Italia è quello di un osservatorio privilegiato all’incrocio delle conoscenze mediche e delle epidemie”. Distesa in uno spazio liquido solcato da un andirivieni di uomini e di cose, la penisola italiana ha presentato nei secoli la ricettività patologica di una geografia umana immersa in un mare epidemico, quale fu appunto il Mediterraneo. La mercantilizzazione dell’economia e gli scambi con paesi lontani ed epidemiologicamente diversi hanno impresso - dalla peste del Trecento al colera dell’Ottocento - un movimento accelerato a quella “unificazione microbica del mondo” che ha precorso l’attuale più vasta “globalizzazione morbosa planetaria”.
In oltre cinque secoli di malattie incombenti επι δεμον (epì dèmon), “sopra il popolo”, l’avvedutezza degli Stati italiani - ducati e repubbliche - seppe organizzare una sanità d’avanguardia imitata dal resto d’Europa. Fedi di sanità per i viaggi di terra, patenti sanitarie per i viaggi di mare, e ancora: cordoni sanitari terrestri e marittimi, disinfezione delle lettere e delle merci, sequestri domiciliari e isolamenti contumaciali, quarantene e lazzaretti, istruzioni per il popolo e magistrature di controllo, questi i principali pilastri di una struttura difensiva articolata e complessa, documentata e rievocata in questa mostra. Il sistema sanitario era finalizzato a evitare il contagio.
Tacito negli Annales (6, 7) lega tra loro il nome contactus e l’aggettivo infectus scrivendo dei “molti che erano infetti come per una malattia contagiosa”; e Isidoro di Siviglia nel IV libro delle Etymologiae (6, 18) scrive del contagium a contingendo, quia quemquem tetigerit, polluit. La definizione è traducibile così: “contagio da contatto, perché inseminò chiunque l’avesse toccato”.
La nozione di contagio infettivo ed epidemico appartiene tanto alla storia dell’umanità quanto alla sua realtà attuale. Se anticamente virus significava “veleno”, oggi esso significa un’entità biomolecolare spesso non meno velenosa, virulenta, violenta. “Il fatto più strano”, ha scritto nel 1912 la penna fantascientifica di Jack London preconizzando la Peste scarlatta dell’anno 2013, “era che ogni giorno comparivano nuovi virus”. È necessario tenere alta la guardia. Oggi la sanità è organizzata su scala mondiale e la medicina è più efficace che in passato: sono due buoni motivi per sperare che sulla minaccia di future epidemie prevalga e sia vittoriosa la strategia congiunta della ragione sanitaria e della ricerca scientifica.
Giorgio Cosmacini
storico della medicina e della sanità